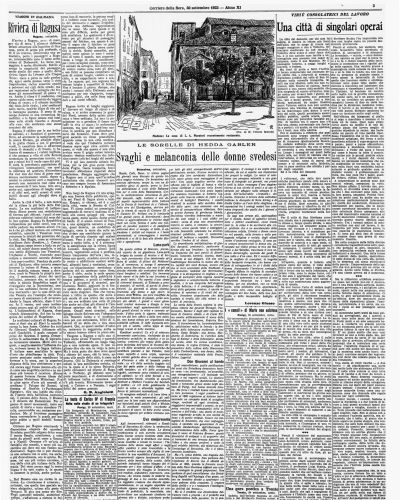La vita nella città bianca
Dove riaffiora il lume della ragione
-
Data di pubblicazione:28 Giugno 1933
-
Titolo:La vita nella città bianca
-
Autore:
-
Testata giornalistica:La Stampa
-
Tag:
VOLTERRA, giugno.
Nello scardinamento degli esseri, due sentimenti sopravvivono e sono l’attrazione verso l’altro sesso, il sentimento della famiglia, dei figli, dei congiunti.
A tratti mi pareva di visitare una comunità di persone esiliate in qualche luogo lontano, di emigranti o di soldati dopo lunghi mesi di trincea.
Apparentemente gli accenti erano gli stessi: la nostalgia, il desiderio di tornare, la curiosità di sapere se l’estraneo che vi capita per la prima volta sia del loro stesso paese.
Accompagnato dall’ispettore che ha un nome antichissimo e dello stesso colore della misericordia, Niccodemo [Nicodemo Dei N.D.R.], qualcuno mi affrontava timidamente: «Sono qui da due anni: ero venuto a cercare mia moglie; m’hanno trattenuto qua; devo tornare a casa».
«Lei è di…».
«Mi conosce? Mi ha mai veduto?».
«Mi pare di averla vista a…».
«Scusi, lei è il prefetto di…».
«Scusi, lei è un’autorità?».
Per un momento erano tutte facce che mi interrogavano e mi studiavano, cercavano di ricordarsi di me, occhi mi scrutavano, mani si tendevano a fermarmi, indici mi chiedevano una parola; per un momento io rappresentavo una speranza, una salvazione, per lo meno qualcuno d’un paese caro, quello che avrebbe potuto ascoltare una parola sincera.
Apparentemente, dico, era lo stesso che in qualche luogo lontano, dove si parla un’altra lingua, e il paese natio è separato da molti giorni di viaggio.
In un attimo vedevo accendersi speranze e illusioni, in un istante le vedevo tramontare per riprendere vive all’apparizione di qualche altro estraneo.
In una cella, qualcuno in istato di crisi, steso nel letto, legato appena da una striscia di tela al disopra dei gomiti, mi aveva cominciato a supplicare; si accorse che neppur io l’ascoltavo; subito cambiò metro dicendo:
«Lo so, sempre così, lo sappiamo, lo sappiamo» e non fece altro che gesticolare come fanno i meridionali quando vogliono significare che non si conclude niente.
Ma un altro ancora, con una voce tenerissima, supplichevole, umilissima, m’implorava e mi aveva quasi fermato, senonché mi dissero che si trattava d’un querulomane:
«È la sua pazzia, supplicare».
Traversato questo reparto, dove erano rinchiusi i più malati, uscito all’aperto, attraverso le grandi e luminose finestre tutti mi chiamavano, bussavano ai vetri, tendevano le mani fuori delle sbarre, e con voci che mi ricordavano certi strani uccelli nelle gabbie dei giardini zoologici attaccati alle gabbie.
Questo era il reparto più impressionante di tutta la città bianca, quello dei furiosi, che in altri tempi e sotto altri regimi scientifici non era che orrore e stridor di denti.
Qui invece erano chiusi in reparti luminosi, stesi in letti puliti.
Avevo rappresentato per poco la loro speranza, la loro salvezza, me ne andavo dolente io stesso di non essere il trionfatore di quel regno buio, un miracoloso uomo che ne avesse potuto aprire le porte.
Ma come faceva la suora dell’Ordine di Santa Caterina a vivere tra costoro?
Nel cortile ella stava tra le sue donne malate, seduta con esse sul muricciolo; la sua vita e quella delle sue consorelle trascorre continuamente in quella compagnia, in quel discorrere ciarlare cantare senza senso.
Ella vi stava come se non ascoltasse, giovane, con la tranquilla dolcezza d’una vita da poco dedicata alle opere buone.
Perché ho già detto che la cosa più evidente di questa comunità è il nessun rapporto fra creature, la totale indipendenza l’una dall’altra, e le sole cose che riescano a far coagulare un poco quegli esseri sono il lavoro e il gioco, e poi soltanto fra uomini il gioco delle carte.
Stanno le malate sedute sulle panchine, hanno tutta l’aria di discorrere fra di loro, e invece nessuna ascolta quel che l’altra dice, nessuna pare sentire il canto dell’altra.
Sono vicine, ed è invece come se l’aria intorno a loro fosse rarefatta, senza vibrazioni né risonanze né echi.
Di quante suore ho veduto dedicate alla pietà del prossimo, queste ho ammirate forse fra tutte.
Ma esse mi raccontano anche qualcosa di gentile di questi poveri esseri, e le premure degli uomini quando una di loro appare; anch’essi sanno offrire un mazzo di fiori.
In un padiglione di malati io ero stato accolto con diffidenza; uno voleva cantarmi una romanza, ma i suoi compagni lo zittirono con tali gesti come se lo giudicassero un essere un po’ strano.
Altri andavano cupi, qualcuno s’era lacerati i vestiti indosso e mi guardava con odio.
Ma nel reparto delle donne esse si affollarono intorno a me, cominciarono a domandarmi di dove fossi, chi conoscessi, e tutte insieme mi raccontavano la loro storia, con la modestia con cui le donne raccomandano le loro pene.
Una dignitosamente mi disse, col più spiccato accento di una regione italiana, d’essere cittadina americana, di trovarsi la dentro ingiustamente, e m’incaricò di cercare a Roma una sua figliola, Carla, a un certo indirizzo:
«Domandi di Carla, di Carla ce n’è una sola».
Dovetti osservare allora quanto resiste ancora nelle menti più ottenebrate dell’attrazione dei sessi.
Il buon Niccodemo [Nicodemo Dei N.D.R.], un uomo forte, dallo sguardo buono ma fermo, con una barba nera quadrata, era fatto segno alle più straordinarie cortesie e sorrisi, qualcuna tentava amabilmente di prendergli la mano, ma con non minor pudore di quanto noi siamo soliti vedere nella vita.
Mentre tra gli uomini la follia è qualcosa di cupo, chiuso, nero, solitario, qui tra le donne era come una debolezza di più in un debole organismo, e le stesse occhiate, la stessa civetteria, lo stesso riserbo d’una qualunque assemblea di donne era il carattere dell’ambiente.
Solo alcune, già interamente spente, mi guardavano fisso, senza dir motto, e come da una distanza enorme.
E altre, ormai vecchie, che non s’erano neppur mosse per vedermi, ridevano di me, di tutte quelle che mi stavano intorno, come d’un giochetto che esse conoscevano, e dicevano:
«Lo so, lo so, lo so».
Questi erano i reparti di ricoverati non dediti al lavoro, poiché il lavoro in questa comunità è libero.
Anche un uomo savio impazzirebbe senza lavoro.
Là dentro ebbi occasione di misurare questa verità.
Nelle favole della Bibbia, non appena l’uomo ebbe un passato, un peccato da scontare, un pensiero su cui attardarsi, fu da Dio condannato a lavorare.
Nella civiltà d’oggi vediamo spaventevoli naufragi appena l’uomo ha superato la necessità del lavoro; ho sempre pensato che il momento più terribile della vita umana sia quando l’uomo sente di aver terminato il suo compito.
Per prolungare la vita non c’è che da trovarsi uno scopo sempre più lontano.
Per questo la riforma audace nel regime di questi malati di mente consiste nell’applicazione al lavoro.
L’attenzione che essi pongono a portare un peso, a costruire una strada, un edifizio, a cucinare, a lavare, è la prosecuzione d’un ritmo di vita, ha una logica per suo conto.
Essi arano, seminano, raccolgono, impastano il loro pane, spremono il loro vino.
E questo è il punto importante: lavorando, hanno la razione di cibo di chi lavora, e il diritto al vino di ogni operaio.
Così questa istituzione si può permettere di tenere i cancelli aperti, e non vi sono muriccioli o reticolati.
Può accadere perfino di incontrare qualcuno di costoro sulla strada (naturalmente non le donne), e il fatto stesso che vi sia una bisogna cui accudire, una responsabilità cui obbedire, un lavoro da proseguire, li lega a quella comunità.
Il risultato di questo trattamento è la cifra altissima dei malati messi in libertà ad ogni fine d’anno: circa il 15 per cento.
Essi lavorano con una diligenza, una forza, con tali risultati che spesso superano le capacità del più diligente operaio.
Uno fra questi è un coltivatore infaticabile, anche se crede che il campo cui lavora è suo dominio.
Così la città bianca si estende, si moltiplicano i padiglioni e le case coloniche, i campi, gli orti.
Oggi occupa cinquecento ettari di terreno coltivabile.
Modi di pensare, di riflettere, di ragionare sono infiniti; ma un solco ha un solo modo, lavorare la terra, piallare il legno, hanno ugualmente un sol modo.
Il bambino, l’uomo, il pazzo, lavorano con lo stesso animo a queste cose che preesistono nell’istinto più profondo dell’uomo.
In una cameretta, con le braccia legate e appena le mani libere, ho veduta una povera malata che faceva un suo ricamo delicatissimo, con un bell’accordo di colori, e sorrideva ai nostri complimenti come una bambina diligente.
Ho veduto una donna che portava un sacco di biancheria nella lavanderia a vapore; si fermò, aveva trovato un bottone di madreperla, e per un attimo si mise a guardare attentamente attraverso i quattro buchi del bottone.
Chissà che cosa vedeva. Poi riprese il suo carico.
A molti uomini sani l’ozio non suggerisce nulla di meno strano che guardare attraverso i buchi d’un bottone.
Essi vivono in lunghe camerate, l’uno accanto all’altro, come in una caserma, nelle ore in cui non lavorano.
Hanno per lavarsi lunghe vasche rettangolari dal cui fondo, attraverso un tubo forato per tutta la sua lunghezza, vengono su a perpendicolo zampilli d’acqua; hanno bagni in mezzo a grandi sale.
Nelle camerate delle donne si affacciano dalle finestre le bambole, pare che entrino in punta di piedi, sui raggi del sole, o siedono sui letti.
Quasi dappertutto dove vi sono donne ho veduto bambole che, sulla parete bianca, su quel vuoto e nudo della pulizia da ospedale, fanno la loro apparizione puerile.
Anche in un reparto di vestiario e di biancheria, due immensi magazzini, più grandi d’un grande magazzino di città, dove per gli scaffali le robe erano disposte a colori diversi e diversi disegni, con stelle, iniziali, quelle bambole facevano la loro apparizione, e sempre con l’aria d’insinuarsi furtivamente in quel mondo.
L’occhio delle ragazze malate che accudivano al lavoro, credeva forse di scorgerle esso soltanto, come un pensiero segreto.
E una di coteste ragazze, piegando certe robe, guardava con gli occhi pudichi delle ragazze che pensano in segreto all’uomo; si poteva dirla graziosa, il suo modo di osservare con la coda dell’occhio, mentre era intenta al lavoro, pareva pieno di pensieri soavi, e dell’eterno gioco della civetteria.
Confesso che in tutti questi luoghi di lavoro, gli strumenti come le forbici, i ferri, i martelli, i coltelli, mi davano un certo timore, come se potessero trasformarsi da un istante all’altro in armi offensive; generalmente evitavo di trovarmi alle spalle una di quelle persone.
Ma si lavorava in silenzio, mi salutavano al mio ingresso con un cenno, e solo nei malati più vecchi, sovratutto nelle donne, notavo uno slancio esagerato nel saluto, una specie di compiacenza nel gesto della mano, come però accade talvolta in campagna, quando si vedono i ragazzi spuntare dalle siepi e salutare esageratamente per un pezzo chi passa e le automobili in corsa.
Qualcuna delle donne arrossiva all’improvviso, e si curvava con troppa attenzione sul lavoro.
Qualcuno degli uomini diventava cupo e biascicava tra sé una domanda che credeva di farmi, ma io non afferravo che sillabe slegate, come di uno parlante in sogno.
In una bottega di falegname, un vecchio e un giovane lavoravano a due banchi; l’uno tagliava certi regoli con una sega elettrica, e in maniche di camicia, il sigaro tra le labbra, si lagnava assai ragionevolmente che i giovani non imparano più il mestiere come una volta.
Prendeva esattamente le misure col metro per certe finestre d’un nuovo padiglione, e faceva giusti i suoi calcoli a memoria.
Il giovane ascoltava quegli ammonimenti e rimpianti con un debole e imbarazzato sorriso, come fanno i giovani che lasciano dire ai vecchi brontoloni.
Seppi, uscendo, che il vecchio operaio amava il vino, e quando aveva qualche soldo lo confidava all’osteria fuori del cancello.
Nella cucina enorme, poi, feci conoscenza con due malati criminali, uno, come dissi, che disossava una coscia di bue con un lungo coltellaccio, l’altro che badava a certe enormi pentole alimentate a vapore dalla centrale sotterranea.
Questi mi guardarono con occhi severi, né facevano a Niccodemo [Nicodemo Dei N.D.R.]le solite raccomandazioni («Mi raccomando, mi faccia venire i vestiti presto, perché sono guarito»).
Questi badavano al lavoro, quello della cucina scoperchiò al mio passaggio le pentole enormi mostrandomi un mare enorme di piselli; l’altro del coltellaccio mi fissò coi suoi occhi rossi e i baffi neri a punta.
Seppi che costui, avendo una volta da dire col suo compagno, posò il coltello per aver libere le mani e fare a pugni.
E a questo punto pensavo che cosa sia il lavoro, che cosa sono i suoi strumenti, armi di cui nessuno sogna di servirsi altro che per il loro scopo, né il macellaio del suo coltello, né il soldato della sua spada.
Prodigiosa trasformazione dell’ingegno umano che attraverso il lavoro ha reso innocue le armi micidiali trionfando della stessa follia.
CORRADO ALVARO